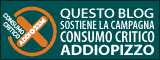No, non mi sto riferendo a quel gioco infantile a coppie, consistente nel sollevarsi a vicenda sul dorso, volgendosi le spalle e intrecciando reciprocamente le braccia.
Oggi voglio riprendere quella "parola" perché rappresenta una consuetudine molto in voga tra i miei connazionali: la tendenza – o dovrei dire la prassi – di chi scarica su altri, incombenze, responsabilità e, soprattutto, problemi.
Ed ecco quindi sfilare tutta una teoria di soggetti che, pur di non accollarsi alcun peso, non fanno nulla. Niente di niente. Anzi, no: per essere precisi, fanno appena il necessario per assicurarsi che qualcun altro si ritrovi il cerino acceso in mano.
Si muovono solo per raccogliere firme, timbri, documenti siglati, preferibilmente in triplice copia, trasmessi a mezzo PEC, ratificati da un collega, controfirmati dal dirigente. Perché? L’importante non è risolvere, ma dimostrare di aver fatto la propria parte.
E allora via con le richieste: "Mi serve una mail di conferma, altrimenti non posso procedere"; "Senza il modulo compilato in ogni sua parte, non c’è nulla che posso fare"; "Ah, ma lei non ha detto che era urgente!" (traduzione: "Io ho fatto il mio, ora affoga pure tu.").
E così, tra un "non è di mia competenza" e un "ma chi me lo fa fare?", beh... il gioco è perfetto. Perché il vero obiettivo non è arrivare a una soluzione, ma costruire un alibi a prova di bomba. Se qualcosa va storto, la colpa sarà sempre di qualcun altro: di chi non ha compilato il campo 12/B, di chi ha inviato il fax con tre minuti di ritardo, di chi non ha previsto l’imprevisto...
E intanto, in questo paese di virtuosi dello "scaricabarile", i problemi restano lì, immobili, come pacchi postali abbandonati in un magazzino. Perché tanto, alla fine, pagherà Pantalone!
E allora, in attesa di ricevere da voi alcuni esempi, il sottoscritto ne ha già pronti parecchi altri e chissà se, in queste analisi, non vi ci ritroviate anche voi…
Non voglio entrare stasera nel merito di casi specifici, in particolare in quelli in cui sono specializzato perché hanno a che fare con i miei incarichi, situazione che mi riprometto comunque di fare a breve, in questo post viceversa, elencherò tutta una serie di situazioni nelle quali ci si accontenta di ricevere una carta o quantomeno di un documento firmato, nel quale si prende per buono tutto ciò che vi è elencato, senza però fare le opportune verifiche, d'altronde, è proprio il nostro Stato che vuole ciò: sì... carte, dove si evincono perfettamente i nomi posti in quella "piramide" delle responsabilità, poi, quanto queste siano veritiere, beh... quello è un altro discorso, di cui a nessuno frega niente!
Ed allora, per il momento accontentatevi di questi esempi.
Innanzitutto l'eterno “Passa-parola”: No, guardi, qui non spetta a me. Si rivolga al collega dell'uffico accanto, oppure, ah... mi dispiace, oggi non c’è, forse lo troverà domani; poi c'è la frase più cordiale, quella da utilizzarsi per tutte le occasioni: No, no, non posso aiutarla, mi dispiace ma non è il mio reparto...
E così, tra un rimpallo e l’altro, il problema invece di essere risolto, rimbalza, già... come una pallina da ping-pong, finché il malcapitato di turno non si arrende o non trova qualche "amico di un altro amico" che si offre (non certo gratuitamente...) per risolvere il problema; ma va detto, c'è anche chi, forse troppo stanco per mandarlo via che si prende cura di quella situazione.
Poi vi sono i perfezionisti, quelli che non fanno nulla se non seguono il corretto procedimento: Sì, certo, possiamo risolvere, ma prima dobbiamo seguire l’iter; come ben sa, l’iter prevede almeno tre autorizzazioni, un’assemblea e anche un timbro in più; mi dispiace vorrei aiutarla, ma no, non possiamo saltare i passaggi previsti dalla normativa vigente: Sì... perché agire con logica quando ci si può nascondere dietro un "regolamento"!
Ed ancora, cosa dire di quelli abituati al "silenzio-assenso": Le ho mandato una mail per conferma, l'ha ricevuta? Mi serve una risposta ufficiale, altrimenti non posso andare avanti; posso quindi considerare il suo silenzio come un sì?; no, assolutamente no! Lei non mi ha dato il tempo di poterle rispondere; e quando tutto sembra perfetto ecco mettersi in pratica una strategia perfetta per far scadere i termini per poter dire: Eh, ma ormai è troppo tardi...
Ovviamente, i casi sopra menzionati rientrano tra quei cosiddetti "scaricabarile" e quindi, compiuti sempre in buona fede. Altra situazione è quando, a seguito di quei rifiuti, si cela una situazione grave e illegale, un meccanismo necessario per promuovere e incentivare una qualche forma di concussione!!!
E allora ditemi... Vi siete mai trovati davanti a un campione di "scaricabarile" e siete pronti a smascherarli?
Ma no, no, no, non sto parlando con voi: già... voi siete tra quelli che i problemi li risolvono, vero? 😉