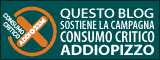Premetto che non lo faccio per giudicare, criticare e ancor meno per essere di parte. Difatti, non ho una religione nel cuore da difendere, né una da attaccare, come d'altronde non credo che una valga più dell'altra, ma ciò che vorrei far comprendere in maniera chiara è quali meccanismi e quali precetti - calati dall'alto come fossero una rivelazione - siano finiti per modellare così profondamente la vita terrena di milioni di persone.
Ed allora, ho deciso - ancora una volta - di riprendere l'argomento, elencando, quasi fosse un inventario, gli obblighi e le ricompense che ciascuna fede pone e promette ai suoi fedeli.
Iniziamo con l'Islam. Ho avuto modo di comprendere, grazie ad alcuni amici musulmani praticanti, quel loro modo di seguire il percorso di vita in maniera precisa, sì... scandito da taluni obblighi. Ad esempio, deve pregare cinque volte al giorno rivolto verso la Mecca, un gesto che orienta non solo lo spirito ma anche il corpo e il tempo quotidiano. Deve digiunare durante il mese di Ramadan dall'alba al tramonto, facendo esperienza della fame e della sete per comprendere la privazione e purificarsi. Deve astenersi dai rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, e in molte interpretazioni osservare regole precise anche all'interno della vita coniugale. Non deve rubare, non deve uccidere, non deve mentire, e deve astenersi dal consumo di alcol e carne di maiale. Deve inoltre praticare l'elemosina legale, la zakat, che è un obbligo preciso, una percentuale dei propri beni da destinare ai poveri. Deve, se ne ha la possibilità fisica ed economica, compiere almeno una volta nella vita il pellegrinaggio alla Mecca. E poi c'è la promessa: vivere secondo queste regole non è solo un modo per guadagnarsi il favore divino in terra, ma apre le porte di un aldilà descritto con straordinaria ricchezza di particolari. Il paradiso coranico è un luogo di giardini e ruscelli, dove i giusti godranno di ogni delizia. E per il martire, per colui che cade combattendo per la fede, la ricompensa è ancora più alta: settantadue vergini lo attendono! Un'immagine quest'ultima che ha affascinato e turbato generazioni di credenti e non solo.
Ed ora passiamo al cristianesimo. Qui l'architettura dottrinale è altrettanto complessa e affonda le radici nel mistero della Trinità: Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo, tre persone distinte ma un'unica sostanza. Il cristiano si fonda sui Vangeli, quei quattro racconti che narrano la vita, la morte e la resurrezione di Gesù, il Cristo (gli altri, sono stati considerati "apocrifi" e non sono stati inclusi nel canone ufficiale del Nuovo Testamento, forse perché mettevano in discussione quei principi...). I suoi fedeli venerano Maria come madre di Dio, figura di intercessione e di purezza assoluta. I precetti di vita sono quelli tramandati dai Dieci Comandamenti e dal messaggio evangelico: amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come se stessi. Non uccidere, non commettere atti impuri, non rubare, non dire falsa testimonianza, onorare il padre e la madre. Ma anche, in molte confessioni, osservare i sacramenti, confessare i propri peccati, partecipare alla messa domenicale, accostarsi all'eucaristia. La vita del buon cristiano è una via che conosce prove e cadute, ma anche la possibilità del pentimento. E poi vi è la ricompensa o la punizione. Oltre la morte, si spalanca il trinomio di possibilità: il Paradiso per i giusti e i pentiti, la beatitudine eterna nella visione di Dio. Il Purgatorio per quelle anime che, morte in grazia di Dio, necessitano ancora di una purificazione prima di accedere alla gioia perfetta. E l'Inferno per i dannati, per coloro che hanno rifiutato consapevolmente l'amore divino, condannandosi a una sofferenza eterna.
Vediamo ora l'ebraismo, che potremmo definire la radice da cui nascono le altre due. Ha un'impostazione in parte diversa, più incentrata sul popolo e sull'alleanza che sul singolo individuo. Il fedele osserva la "Torah", la legge rivelata, che comprende precetti numerosissimi, come il riposo assoluto durante lo Shabbat, dal venerdì sera al sabato sera. Segue le regole alimentari della kasherut, che distinguono gli animali puri da quelli impuri e vietano di mescolare carne e latte. Pratica la circoncisione come segno dell'alleanza con Dio. La vita è scandita da feste che ricordano la storia della salvezza del popolo ebraico, come la Pasqua, che celebra l'uscita dall'Egitto. La ricompensa, nell'ebraismo, è spesso terrena e collettiva: la venuta del Messia, la pace per Israele, la giustizia nel mondo. Quanto all'aldilà, le visioni sono meno definite e variegate, con l'idea di uno "Sheol", un luogo ombroso dove i morti attendono, e in alcune correnti, la speranza nella resurrezione dei corpi alla fine dei tempi.
Se poi ci spostiamo verso Oriente, l'induismo offre ad esempio un panorama totalmente complesso e stratificato. Il fedele induista vive secondo il proprio "dharma", il dovere specifico legato alla casta di appartenenza e alla fase della vita. I precetti variano enormemente, ma includono la purezza rituale, il rispetto per tutte le forme di vita, che si traduce spesso nell'esser vegetariani e nella venerazione di migliaia di divinità, con pratiche che vanno dalla semplice preghiera domestica, ai complessi rituali templari. Il cuore della promessa induista è il ciclo delle reincarnazioni, il "samsara". Ogni azione, ogni pensiero, ogni parola produce un karma, un frutto che determinerà la qualità della prossima vita. Si può rinascere in una casta superiore o inferiore, o addirittura come animale o insetto. La meta ultima, il moksha, è la liberazione da questo ciclo, l'uscita dalla ruota delle rinascite, il ricongiungersi con l'assoluto, il "Brahman".
E poi ci sono le tante ramificazioni, le tante interpretazioni che hanno dato vita a confessioni diverse. I Protestanti, nati dalla riforma di Lutero, che rifiutano l'autorità del Papa, riducono i sacramenti a due, battesimo ed eucaristia, e pongono la sacra scrittura come unica fonte di autorità, sostenendo la dottrina della giustificazione per sola fede. La salvezza non si guadagna con le opere, ma è un dono gratuito di Dio, accolto appunto attraverso la fede.
I Calvinisti, che dalla Riforma protestante ereditano molto ma aggiungono un tassello teologico tra i più radicali e affascinanti da analizzare. Anche loro, come i luterani, riconoscono la Scrittura come unica regola di fede e rifiutano gran parte dei sacramenti, conservando solo battesimo e cena eucaristica, quest'ultima intesa però in senso puramente simbolico, senza alcuna presenza reale di Cristo. Ma il cuore della loro dottrina, ciò che rende il calvinismo un unico nel panorama delle fedi cristiane, è la doppia predestinazione. Secondo questa visione, Dio, nella sua assoluta sovranità e onnipotenza, ha stabilito dall'eternità chi sarà salvato e chi sarà dannato. Gli eletti, coloro che sono destinati alla gloria eterna, non lo sono per merito, per le opere compiute o per la fede professata, ma per un decreto divino insondabile, precedente a qualsiasi azione umana. Il fedele calvinista vive quindi sulla terra senza la certezza della propria sorte, ma cerca nel successo terreno, nella prosperità del lavoro, nella disciplina e nella condotta morale irreprensibile un segno, un indizio della propria elezione: Il lavoro diventa vocazione, l'impegno civile un dovere, la sobrietà uno stile di vita. Ecco che allora, paradossalmente, una dottrina che sembrerebbe togliere ogni spazio alla libertà umana diventa il motore di un'etica operosa e disciplinata, la ricompensa quindi non si guadagna, ma la si riconosce nei frutti terreni della propria esistenza, in attesa del giudizio eterno già scritto.
Passiamo quindi ai Testimoni di Geova, che non amano definirsi una confessione cristiana ma piuttosto un ritorno al cristianesimo delle origini, rifiutano la Trinità, non festeggiano compleanni e natale perché li ritengono di origine pagana, rifiutano le trasfusioni di sangue basandosi su un'interpretazione letterale di alcuni passi biblici, e non prestano servizio militare. La loro speranza è vivere per sempre su una terra paradisiaca, ricreata dopo la battaglia di Armageddon, e non in cielo, dove andranno solo un numero limitato di eletti, i 144.000!
I Mormoni, o Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, aggiungono ai testi biblici il "Libro di Mormon", che racconterebbe la visita di Gesù alle Americhe dopo la resurrezione. Praticano il battesimo dei morti, offrendo la salvezza anche agli antenati, e in alcuni periodi storici hanno praticato la poligamia. Credono in una vita eterna che è una progressione continua, dove gli uomini più giusti possono diventare a loro volta dèi e governare su propri mondi.
E potrei continuare con i buddhisti, che pure non parlano di un dio creatore, ma di un percorso di illuminazione e di distacco dalla sofferenza attraverso l'ottuplice sentiero, con la meta finale del nirvana, l'estinzione del desiderio e quindi del ciclo delle rinascite. Oppure con gli scintoisti giapponesi, che rappresentano un caso a sé nel panorama delle fedi mondiali. Lo shintoismo è la via dei kami, gli dèi-spiriti che abitano ogni cosa: non un dio unico e lontano, ma una miriade di presenze che risiedono negli alberi secolari, nelle montagne, nei fiumi, nelle rocce, persino negli oggetti e negli antenati illustri divinizzati dopo la morte. Il fedele scintoista non segue un libro sacro né un codice morale scritto, perché la virtù si presume naturale nel popolo giapponese. Ciò che conta è la purezza, intesa come assenza di contaminazione, da ottenere attraverso riti di purificazione con acqua o con rami di sakaki agitati dai sacerdoti. I precetti non sono comandi da osservare, ma uno stato da mantenere: evitare ciò che sporca, ciò che offende i kami. Le feste, i matsuri, scandiscono l'anno agricolo e servono a ringraziare per il raccolto, a invocare la fertilità, a mantenere l'armonia tra il mondo umano e quello divino. Quanto all'aldilà, lo shintoismo non promette paradisi né inferni, non minaccia pene eterne né ricompense ultraterrene. I morti dimorano nella terra di Yomi, un luogo ombroso e indefinito separato dal mondo dei vivi da un basso colle. La vera ricompensa è qui, sulla terra: la protezione dei kami, la fertilità dei campi, la serenità della comunità. Un meccanismo questo che funziona al contrario delle religioni abramitiche: non si obbedisce per guadagnarsi l'aldilà, ma si celebrano i riti per preservare l'equilibrio del mondo in cui già si vive.
E poi ci sono i sikh, che dal crogiolo indiano emergono con una fede giovane e decisa, nata cinquecento anni fa dall'insegnamento di dieci guru. Per loro Dio è uno, senza forma, e si raggiunge attraverso la meditazione e il servizio disinteressato. Il fedele porta con sé i cinque simboli distintivi, i cosiddetti cinque K: i capelli lunghi mai tagliati, raccolti sotto il turbante; il pettine di legno; il bracciale d'acciaio; il pugnale cerimoniale; e i pantaloni particolari, segno di prontezza a difendere i deboli . Il loro tempio, il "gurdwara", è aperto a tutti senza distinzione di casta o credo, e lì si consuma insieme il pasto sacro, il "langar", preparato e offerto dai fedeli stessi in segno di uguaglianza. La ricompensa è la fusione dell'anima con Dio, come una goccia che torna all'oceano, dopo aver vissuto una vita onesta e laboriosa.
Andando per concludere troviamo i giainisti, questi, portano all'estremo il principio della non violenza, l'ahimsa, al punto che i monaci più austeri camminano scoprendo il terreno davanti a sé con una scopa per evitare di schiacciare insetti, portano una mascherina per non uccidere microscopiche forme di vita nell'aria e bevono acqua filtrata. La loro dottrina insegna che ogni anima, ogni "jiva", è potenzialmente divina e imprigionata nel ciclo delle rinascite a causa del karma, inteso qui come una sostanza sottile che aderisce all'anima per le azioni compiute. Liberarsene richiede un'ascesi estrema, un digiuno progressivo fino alla morte che alcuni monaci scelgono come atto supremo di distacco. La meta, il "moksha", è la liberazione definitiva, la beatitudine eterna nella conoscenza perfetta, raggiunta solo da quelle anime che hanno spento ogni desiderio e ogni violenza.
Ed infine vi sono le religioni animistiche africane, quelle che i manuali chiamano spesso religioni tradizionali, come se il termine racchiudesse in sé qualcosa di primitivo o di superato. In realtà, sono sistemi complessi e profondi, dove il confine tra visibile e invisibile è labile, dove gli spiriti abitano gli alberi, gli animali, i luoghi sacri, e gli antenati non sono morti davvero ma vegliano sui discendenti da una dimensione parallela. Non c'è un dio unico e lontano, ma un dio creatore, spesso distaccato, e poi una miriade di divinità minori, di spiriti della natura, di forze con cui l'uomo deve imparare a convivere. I precetti sono tramandati oralmente, custoditi dagli anziani e dagli sciamani, e riguardano il rispetto per gli antenati, l'equilibrio con la natura, la purezza rituale da mantenere. Le offerte, i sacrifici, le danze non servono a guadagnarsi un paradiso futuro, ma a mantenere l'armonia qui e ora, a placare gli spiriti irati, a chiedere pioggia o fertilità. La ricompensa è immediata, concreta: la salute, il raccolto, la protezione della comunità. L'aldilà è un prolungamento sfumato della vita terrena, un mondo degli spiriti dove si continua a esistere, magari con meno peso, ma sempre in relazione con i vivi.
Quanto sopra, vuol far comprendere come, tra fedi e precetti, emerga la straordinaria varietà di risposte che l'umanità ha saputo darsi alle stesse domande e, allo stesso tempo, la sorprendente uniformità della struttura: da un lato un codice di comportamento, un insieme di regole da seguire quaggiù, dall'altro la promessa di una ricompensa, o la minaccia di una punizione, in un aldilà.
Nello scrivere questo post pensavo dentro me che, se ci fosse un extraterrestre a osservarci, direbbe di noi: una vera e propria architettura di bisogni e speranze quella degli umani, che, visti da fuori, rivelano tutta la loro terrena e misera umanità.
Sì... forse soltanto un definitivo contatto con quegli esseri, con qualcosa di così radicalmente diverso da noi e dalle nostre costruzioni mentali, potrà finalmente portare alla fine di tutte queste religioni. Sì... chissà se basterà la prova vivente di un'altra intelligenza, di un'altra forma di vita cosciente, per frantumare il millenario specchio in cui ci siamo guardati credendo di vedere il riflesso di un dio o chissà, se viceversa - e questa è l'ipotesi più amara - anche di fronte all'evidenza più lampante, l'essere umano troverebbe il modo di riplasmare la propria fede, integrando gli alieni nel proprio disegno divino.
Sì... magari come angeli, come demoni, o come nuove anime da convertire, perché l'illusione, quando è così radicata, non muore davvero, si adatta, si trasforma, e continua a vivere.
Perché in fondo, la mia specie è fatta così: ha troppo bisogno di credere in qualcosa, anche a costo di credere in niente!