Ed allora mi chiedo cosa rimanga del significato originario di quella parola, quando ormai è diventata merce di scambio nelle trattative internazionali, o peggio, l'incipit di una condanna a morte pronunciata da uno Stato contro la propria gente.
Perché è questo l'esito estremo di quel linguaggio avvelenato: dal 10 gennaio, il Procuratore generale e i giudici iraniani condannano pubblicamente i manifestanti come "mohareb": coloro che muovono guerra a Dio, un reato punibile con l'esecuzione capitale!
Ecco il terrorismo vero - quello che semina paura tra la gente comune, che colpisce chi non ha voce nelle cancellerie - quello si nutre proprio di questa spirale di ritorsioni verbali che sfociano in provvedimenti concreti e spietati.
Ogni volta che uno Stato alza la posta con una dichiarazione simbolica, si allontana di un passo dalla possibilità di sedersi a un tavolo e parlare da esseri umani. E intanto i cittadini, da una parte e dall'altra del mondo, pagano il prezzo di un linguaggio che ha smarrito la sua capacità di costruire ponti, sostituita dalla volontà di erigere muri di paura e silenzio.
Non si tratta di giustificare o condannare una parte contro l'altra: sarebbe ingenuo e soprattutto fuorviante. Si tratta piuttosto di osservare con lucidità come certe decisioni, prese forse per rafforzare una posizione interna o per compiacere alleati lontani, finiscano per irrigidire ulteriormente un sistema già fragile. La Guida Suprema Ali Khamenei, il 3 gennaio, ha definito i manifestanti "rivoltosi e da rimettere al loro posto", e da quel momento la repressione ha assunto caratteristiche militari senza precedenti.
Comprendo i tempi della diplomazia - anche se non li approvo - tempi che solitamente richiedono pazienza, capacità di guardare oltre l'offesa immediata, un respiro lungo che troppo spesso manca quando prevale la logica dello scontro frontale, quando si invita pubblicamente la magistratura a non mostrare "alcuna clemenza".
E così quel respiro si spegne nel piombo: forze di sicurezza posizionate sui tetti sparano con fucili e pallini di metallo, spesso mirando alla testa e al torace di persone inermi, mentre gli ospedali vengono presi d'assalto e i feriti strappati dalle corsie per paura di essere arrestati.
E mentre i nostri parlamenti si scambiano accuse come fossero biglietti da visita, mi torna in mente una semplice verità da cantiere: quando due muratori litigano sulle fondamenta, è l'intero edificio a rischiare di crollare.
Oggi, le fondamenta della società iraniana sono scosse da una crisi economica profondissima, dal crollo della valuta nazionale e dalla disperazione per servizi essenziali negati, mentre la risposta dello Stato è un blackout informativo totale che isola oltre novanta milioni di persone dal mondo, e pattuglie pesanti che impongono coprifuoco in una situazione di controllo militarizzato.
Non servono quindi gesti plateali per dimostrare forza, servono mani capaci di impastare il cemento del dialogo anche quando l'aria è piena di polvere e rancore, perché alla fine, a pagare lo scotto di queste dichiarazioni incrociate non saranno i politici nei loro uffici, ma chi ogni giorno spera di attraversare una strada, commerciare un bene, sciogliersi i capelli, studiare ed esporre le proprie idee, vivere semplicemente liberi, senza il peso costante della paura.
Basta quindi a famiglie a cui viene imposto di seppellire i propri cari nella notte, sotto stretta sorveglianza, parenti costretti a dichiarare falsamente che i figli uccisi erano membri dei Basij, solo per riaverne il corpo; già... come quel padre, ripreso in una video-propaganda di regime, che ripete a comando la versione dello Stato sulla morte della propria bambina di due anni.
Forse il vero atto rivoluzionario oggi non è dichiarare qualcuno terrorista, ma rifiutarsi di entrare nel gioco delle etichette e ricordare a tutti che dietro ogni bandiera ci sono volti, storie, desideri di pace che nessuna risoluzione parlamentare potrà mai cancellare.
È ascoltare il grido che viene da Kahrizak, dove i video mostrano oltre duecento sacchi per cadaveri ammassati in un obitorio improvvisato, o la disperazione di chi cerca un figlio scomparso dopo un raid notturno in casa. È riconoscere che l'impunità sistematica per i crimini del passato ha alimentato questa nuova ondata di violenza, e che senza una svolta reale, le minacce lanciate oggi dai palazzi del potere verso il mondo esterno saranno nulla rispetto al crollo che si prepara dentro.
Perché quando un regime, per sostenersi, deve sparare sulla propria gioventù, oscurare internet e minacciare le madri in lutto, ha già perso ogni legittimità agli occhi della storia e, soprattutto, del suo stesso popolo.
E a quel punto, ai suoi vertici e alle loro famiglie, non resta che una strada: accettare l'offerta di un esilio dorato verso una terra ancora amica, con i lingotti d'oro frutto di decenni di saccheggio stretti al petto, e partire immediatamente.
Perché l'alternativa potrebbe essere che dall'Iran non esca più nessuno, e che qualsivoglia aereo in partenza venga fatto precipitare – già, lo stesso metodo cinicamente sperimentato e poi fatto passare per un disastro aereo, utile a epurare in un colpo solo l'allora presidente Ebrahim Raisi e i suoi alti esponenti.
Un cerchio di sangue e sospetti che, alla fine, potrebbe chiudersi proprio su chi l'ha aperto.





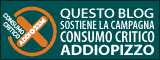

Nessun commento:
Posta un commento