L’indagine ha ricostruito con cura come, dietro le facciate di associazioni benefiche, una parte consistente dei fondi raccolti a nome dei civili di Gaza venisse dirottata verso le casse del gruppo, seguendo flussi di denaro articolati su scala internazionale. È l’immagine di un’organizzazione che non sopravvive per caso, ma grazie a un’architettura finanziaria globale, sapientemente dissimulata dietro la sacralità del soccorso a un popolo in sofferenza, e proprio per questo difficile da smascherare.
Questa realtà obbliga a riconsiderare le dinamiche profonde che tengono in vita il conflitto. Quando sento parlare di disarmo di Hamas, come previsto da alcuni piani di pace, la mia prima reazione non è di speranza, ma di scetticismo, perché mi chiedo: perché mai un gruppo che ha costruito il proprio potere sulla forza militare dovrebbe rinunciarvi di propria iniziativa?
Le sue milizie, nonostante due anni di guerra intensa, rimangono numerose e ben strutturate, e i suoi leader, pur colpiti in più occasioni dai servizi segreti israeliani, continuano a operare, spesso al sicuro fuori da Gaza, protetti da confini e giurisdizioni compiacenti. Per loro, la lotta armata non è uno strumento contingente, ma un diritto inalienabile, un pilastro identitario e strategico inscindibile da un più ampio progetto politico, ovvero la creazione di uno stato palestinese, un obiettivo ancora ostacolato, con tenacia, da molte potenze regionali e internazionali.
È qui che emerge il cuore della questione, non ideologico ma geopolitico. La resilienza di Hamas non si spiega soltanto con la fede o il rancore, ma con una rete fitta di sostegni esterni, dove paesi che si presentano pubblicamente come mediatori di pace hanno storicamente finanziato e ospitato i suoi vertici, vedendo in esso non un nemico da neutralizzare, ma uno strumento per proiettare influenza, destabilizzare avversari, o semplicemente mantenere aperto un fronte utile ai propri equilibri di potere.
Questi attori, mossi da un’opposizione strategica a Israele o dalla necessità di bilanciare le forze nella regione, garantiscono a Hamas una linfa vitale che va ben oltre le donazioni raccolte sotto falsi pretesti umanitari. La lotta armata diventa così un’attività strutturata, sostenuta da capitali, protezione diplomatica e alleanze informali, e ogni tentativo di disarmo si arena in un labirinto di veti incrociati, doppi giochi e obiettivi celati.
Ne deriva un’impasse non casuale, ma calcolata. Da un lato si evocano forze internazionali di stabilizzazione o governi tecnici, ma questi progetti si infrangono sulle reciproche diffidenze e su condizioni che nessuna parte è disposta a soddisfare. Chi dovrebbe garantire la sicurezza rifiuta di collaborare con chi detiene influenza reale sul campo, e chi dovrebbe sostituire le armi con istituzioni credibili è considerato troppo debole o inaffidabile per assumersi il compito.
E nel mezzo, c’è sempre Gaza. Una popolazione usata due volte: prima come copertura emotiva per raccogliere fondi che poi alimentano il terrore, poi come pedina in una partita più grande, dove il suo vero interesse, il suo bisogno di pace, di ricostruzione, di dignità, viene costantemente sacrificato sull’altare di calcoli finanziari e disegni di potere che non le appartengono.
Per questo ritengo che l’operazione di Genova non sia un caso isolato, ma un campanello d’allarme chiaro, un sintomo visibile di come la perpetuazione del conflitto non sia una semplice tragedia, ma una scelta funzionale a molti, mentre il prezzo, sempre lo stesso, continua a essere pagato da pochi.
La cosa più assurda, forse, è che in molti, anche nel nostro governo, hanno avuto il coraggio di celebrare la fine di un conflitto che non è mai finito, visto che proprio in queste ore l’artiglieria israeliana sta bombardando il sud del Libano e gran parte della Striscia di Gaza.





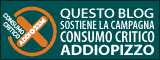

Nessun commento:
Posta un commento