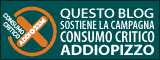Buongiorno, oggi ho deciso di affrontare un argomento che in questi giorni si è diffuso rapidamente tra le pagine dei social, sollevando reazioni contrastanti e silenzi eloquenti: la morte di Charlie Kirk, ucciso il 10 settembre 2025 a Orem, nello Utah, da un colpo d’arma da fuoco, lasciando la moglie e due figli.
Ammetto che non conoscevo Kirk prima di questa notizia, né avevo mai seguito il suo lavoro. La verità è che tendo a stare alla larga da chi usa toni estremi, soprattutto quando quei toni sono rivolti ai giovani, veicolati con la forza dell’ideologia piuttosto che del dialogo.
Ricordo vagamente, di essermi imbattuto in una pagina social su X, già... in una sua clip: parlava con voce decisa, sguardo fisso, mentre smontava concetti complessi in frasi brevi e martellanti. Ma ascoltandolo, ho trovato le sue argomentazioni così sterili, prive di profondità, che non mi sono più soffermato su di lui. Ecco perché non ho più cercato altri interventi e ancor meno ho voluto approfondire quei suoi ragionamenti...
Forse quella volta è stata l’unica in cui gli ho prestato un minuto della mia attenzione, già...finché la notizia della sua morte non ha riportato il suo nome al centro della discussione. Eppure, nonostante quella mia distanza iniziale, ho sentito in questi giorni il bisogno di comprendere chi fosse davvero, al di là degli elogi postumi o delle polemiche virali sui social.
Mi sono dedicato quindi ad ascoltare in questi giorni le sue parole, leggere alcuni suoi testi, vedere i dibattiti, senza farmi influenzare da chi oggi lo celebra come martire o da chi lo deride come ciarlatano. Volevo partire da lui, dal suo messaggio, per poi chiedermi: cosa c’era dietro tutto questo? Perché tanta attenzione ora, dopo anni di discorsi incendiari? E soprattutto, perché certe figure riescono a radunare così tanta folla intorno a idee che, se analizzate con calma, appaiono fragili, anacronistiche e talvolta pericolose?
Partiamo da una frase che lui stesso ha trasformato in slogan: “Prove Me Wrong”, dimostrami che sbaglio. Suona come una sfida onesta, aperta, quasi scientifica. Ma nel contesto in cui veniva usata, diventava un’arma retorica, non uno strumento di ricerca della verità. Lo diceva seduto sotto un tendone con quella scritta, invitando studenti universitari a confrontarsi con lui, spesso giovanissimi, impreparati, visibilmente intimiditi. Li lasciava parlare, li ascoltava con aria compiaciuta, poi li smontava con precisione chirurgica, usando logiche stringate, esempi distorti, a volte semplice sarcasmo.
Il pubblico applaudiva, i video diventavano virali, il mito del “debater imbattibile” cresceva. Ma era davvero un confronto? Oppure una sceneggiatura ben studiata, dove l’avversario serviva solo a far brillare il protagonista? Mi viene in mente Tracy Asè-Shabazz (Assistente Amministratore presso la St. George's University a Grenada), che dopo averlo visto all’opera disse: “Kirk va nei campus a discutere con bambini. Non può discutere con persone della sua età”. Ecco, forse in quelle parole c’è tutta la sostanza del metodo: non cercare il dialogo, ma la vittoria mediatica. Creare spettacolo, non riflessione.
E allora proviamo a guardare alle sue posizioni, non per demolirle con odio, ma per capire come abbiano potuto attecchire in così tanti. Sì, parlava contro Big Tech, contro i media mainstream, contro il governo troppo grande, contro l’élite accademica. Prometteva libertà individuale, sovranità del cittadino, il ritorno ai valori della famiglia, delle piccole imprese, della Costituzione originale. Tutto questo risuona in un’epoca in cui molte persone si sentono escluse, ignorate, tradite dalle istituzioni.
Ed è qui che il suo messaggio diventa potente: non perché sia profondo, ma perché arriva dritto al cuore di chi si sente invisibile. Diceva di voler rompere la “camera d’eco liberale”, mostrare che la sinistra sui campus ha paura del confronto. Ma il confronto che proponeva era spesso un monologo travestito da dialogo, una guerra culturale presentata come difesa della verità. Parlava di aborto come di una questione assoluta, pro-life senza compromessi, arrivando a dichiarare che anche se sua figlia di dieci anni fosse stata violentata e rimasta incinta, avrebbe voluto che portasse a termine la gravidanza. Sul clima, negava il ruolo dell’uomo nel cambiamento climatico. Sul Covid, sminuiva l’importanza dei vaccini e dei lockdown. Sul Secondo Emendamento, sosteneva il diritto a possedere armi a ogni costo, persino se significava accettare morti annuali come prezzo inevitabile.
E poi c’erano i temi più esplosivi: l’immigrazione, che secondo lui era parte di una “Grande Sostituzione”, un piano per cancellare l’America bianca e rurale; i diritti transgender, che definiva una “delusione woke”, parlando di trans donne come uomini con “autoginefilia”, un termine pseudoscientifico respinto dalla comunità medica; il movimento Black Lives Matter, che riduceva a una narrazione basata sul privilegio bianco, mentre attribuiva i problemi della comunità nera all’assenza del padre in casa, cancellando decenni di studi sul razzismo sistemico. Ha detto, durante un dibattito, che forse era più facile per una persona nera entrare alla University of Florida che per una bianca. Frasi così non sono semplici opinioni: sono semina di divisione. Eppure, proprio per questo, funzionano. Perché creano identità attraverso il nemico: il politicamente corretto, il woke, il globalista, il burocrate. E chi grida più forte contro questi mostri, diventa un paladino.
Ma come si arriva a sparare a un uomo per le sue idee? È questo il punto che non riesco a superare! Nessuno merita di morire per ciò che pensa, neanche quando quel pensiero è tossico, miope, dannoso. I tempi dell’inquisizione dovrebbero essere finiti, e invece sembra che qualcuno abbia deciso di riprenderli in mano, con una pistola.
E allora mi chiedo: chi alimenta questo clima? Chi trasforma il disaccordo in odio, la critica in demonizzazione? Perché ora, dopo la sua morte, sento certi politici italiani – eviterò di nominarli – esprimere cordoglio per Kirk, lodarlo come difensore della libertà, quando è evidente che molti di loro non hanno mai ascoltato un suo podcast, letto un suo libro, né tantomeno compreso il senso della sua battaglia!
È ipocrisia? Opportunismo? O forse condividono in silenzio quel mondo che lui rappresentava? Perché altrimenti celebrare un uomo che ha fatto della provocazione un mestiere, che ha costruito un impero su divisione e paura?
Ho ascoltato alcuni dei suoi episodi, visitato il suo sito, osservato i suoi dibattiti. C’è qualcosa di magnetico in lui, lo ammetto: carisma, sicurezza, capacità di sintesi. Ma c’è anche una totale mancanza di autoreflexività, un’incapacità di mettersi in discussione che stride con lo slogan “Prove Me Wrong”.
Perché se davvero avesse voluto mettersi alla prova, avrebbe scelto interlocutori preparati, seri, capaci di ribattere con dati e argomenti, non studenti emozionati o attivisti improvvisati. Invece ha preferito il il teatro, il conflitto, il dominio, gia come molti nostri politicanti!
E il risultato è un circolo vizioso: più polarizza, più cresce il suo seguito; più cresce il suo seguito, più aumenta l’odio verso di lui. Fino al gesto estremo. E ora che è morto, rischia di diventare un simbolo ancora più potente di quando era vivo. Trump, pare, voglia assegnargli postuma la Medaglia Presidenziale della Libertà. Un gesto politico, certo. Ma anche un acceleratore di mito, per non dire l'ennesima cazz...
Tutto questo mi lascia con un groviglio dentro. Da un lato, condanno con forza le sue posizioni, che considero regressivo, culturalmente arretrate, spesso crudeli. Dall’altro, non posso accettare che la violenza sia diventata l’ultima parola del dissenso. E nel mezzo, vedo un paese – e non parlo solo degli Stati Uniti – sempre più frammentato, dove la parola è stata sostituita dal grido, il ragionamento dal like, il dibattito dal tifo, e dove persino le affermazioni più incredibili vengono pronunciate con sicumera nei palazzi delle istituzioni, come se la realtà potesse piegarsi alla retorica.
L’ultima l’ho ascoltata in questi giorni nei Tg, dal Palazzo di Vetro dell’ONU, quando il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato con orgoglio di aver concluso sette guerre durante il suo mandato. Sette guerre. Ma quale guerre? Di quali conflitti parlava? Perché non ne ho mai sentito nominare una? Non una firma su un trattato, non un annuncio internazionale, nessuna cronaca che documenti la fine di un solo conflitto armato sotto la sua guida. Eppure l’ha detto così, come se fosse un dato incontrovertibile, mentre nella sala scendeva un silenzio imbarazzato, subito coperto dagli applausi dei suoi sostenitori. Una frase vuota, forse perfino inventata, ma efficace: perché nell’era dello spettacolo, basta che suoni forte per sembrare vera.
Ho già scritto in passato che stavamo andando verso derive violente. Forse, in cuor mio, speravo di sbagliarmi. Ma ormai devo ammettere che, purtroppo, in quindici anni di post, i miei timori si sono rivelati quasi sempre fondati. E ogni volta che una mia previsione si è avverata, il prezzo è stato alto.







.jpg)