Era l’inizio di qualcosa di più grande di uno sciopero: era l’alba di una rivolta pacifica contro un sistema che, pur chiamandosi “popolare”, aveva smarrito ogni contatto con il popolo. Il governo polacco di allora, infatti, non era che un’ombra obbediente alle direttive di Mosca, un burattino mosso da fili tirati dall’impero sovietico, che da decenni imponeva il proprio ordine con la forza e la paura.
Ma quando il malcontento supera certi limiti - quelli oltre i quali il pane manca, la dignità viene calpestata e la speranza sembra spenta - allora anche il più silenzioso dei popoli trova la voce. E quella voce, a Danzica, prese forma nel grido di un sindacato libero: Solidarność.
 Non era mai accaduto prima, non in un Paese del blocco sovietico. Un’organizzazione operaia indipendente, nata dal basso, senza il controllo del partito, capace di unire non solo i lavoratori dei cantieri, ma intellettuali, studenti, contadini, preti, famiglie intere.
Non era mai accaduto prima, non in un Paese del blocco sovietico. Un’organizzazione operaia indipendente, nata dal basso, senza il controllo del partito, capace di unire non solo i lavoratori dei cantieri, ma intellettuali, studenti, contadini, preti, famiglie intere. Fu lui a ricordare ai polacchi, e a tutti i popoli sotto il tallone sovietico, che la loro dignità non dipendeva dal permesso di un regime, ma era un dono inalienabile. E quel seme germogliò ben oltre i confini della Polonia: in Ungheria, in Cecoslovacchia, in Germania Est, fino a quando, nel 1989, il Muro di Berlino cadde non con il fragore delle bombe, ma con il rumore delle voci che finalmente potevano parlare libere.
 Il tempo è passato, e l’Europa è cambiata. Quelle nazioni un tempo divise da filo spinato e ideologie opposte oggi condividono moneta, istituzioni, sogni.
Il tempo è passato, e l’Europa è cambiata. Quelle nazioni un tempo divise da filo spinato e ideologie opposte oggi condividono moneta, istituzioni, sogni. Eppure, guardando al presente, non si può fare a meno di notare con una certa amarezza che molti di quei valori - la libertà di parola, il rispetto per le minoranze, la democrazia partecipata - sembrano oggi dati per scontati, o peggio, messi in discussione.
In un’epoca in cui la verità viene manipolata, in cui la solidarietà è spesso sostituita dalla paura dell’altro, e in cui la storia rischia di essere dimenticata, il ricordo di Danzica non è solo un omaggio al passato, ma un monito urgente per il futuro.
Perché la libertà non è un bene acquisito una volta per tutte: è un impegno quotidiano, una scelta che ogni generazione deve fare, con coraggio, con lucidità, con lo stesso spirito che animò quegli operai quarant’anni fa.





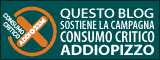

Nessun commento:
Posta un commento