Questo schifo di politica, gonfia di potere e intrisa di privilegi, ha trasformato la gestione della cosa pubblica in un affare privato, un mercato sommerso dove ogni decisione è un debito da saldare con un favore, ogni posto di lavoro una ricompensa per chi ha baciato l’anello al momento giusto.
Quelli che abbiamo eletto per rappresentarci, per lavorare per tutti, hanno invece interpretato il mandato come un diritto ereditario, una specie di investitura divina a spartirsi ricchezze, appalti, poltrone, come se la città fosse una villa di famiglia da dividere tra eredi. E il peggio? Che lo fanno con la spudoratezza di chi crede di essere nel giusto, di chi si guarda allo specchio e vede un benefattore, non un parassita.
Forse il problema sta proprio in quelle parole mal interpretate, in quel “governare come il buon padre di famiglia” che hanno preso alla lettera, ma nel modo più distorto, più meschino possibile. Per loro, essere “buoni padri” non significa avere cura del paese, ma garantire che i figli abbiano un posto in Comune, che i cognati gestiscano le gare d’appalto, che gli amici più fedeli trovino sempre una raccomandazione pronta presso uno degli uffici. E i concorsi pubblici? Una farsa, una sceneggiata dove i copioni sono scritti mesi prima e gli attori principali sono sempre gli stessi, quelli che non hanno mai aperto un bando ma sanno già dove finirà il posto.
E mentre tutto questo accade, mentre il denaro pubblico diventa moneta di scambio per lealtà personali, mentre le opere incompiute marciscono sotto il sole e i giovani scappano all’estero, mi chiedo: ma le Procure dove sono? Dormono? O forse, anche lì, qualcuno ha deciso che certe cose è meglio non vederle, che certi nomi vanno trattati con riguardo, che certe inchieste potrebbero far cadere troppi alberi in un bosco già malato?
Lasciate quindi che vi racconti una storia, una di quelle che sembrano uscite da un romanzo grottesco, ma che purtroppo è vera, anzi, quotidiana. Un Comune etneo, piccolo ma non troppo, dove le dinamiche di potere si intrecciano con affari, favori e raccomandazioni come radici in un terreno avvelenato. E la cosa più agghiacciante? Che non è l’unico. È solo uno dei tanti anelli di una catena che sembra non avere fine, un sistema che si ripete identico in cento paesi, in cento province, con volti diversi ma stesse mosse, stessi silenzi, stesse complicità.
Ma la domanda che resta, alla fine, è sempre la stessa: fino a quando continueremo a permettere che tutto questo accada? Fino a quando lasceremo che il bene di tutti diventi il bottino di pochi, che la speranza si trasformi in rancore e il rancore in rassegnazione?
Il sottoscritto pensa – ahimè – che non cambierà mai nulla in questo nostro Paese. È un circolo vizioso che si autoalimenta, perché in fondo ai miei connazionali piace questo sistema clientelare, lo tollerano, lo subiscono, ma segretamente sperano di poterne usufruire un giorno, quando toccherà a loro. È un gioco di specchi dove tutti fingono di indignarsi, ma nessuno rompe davvero lo schema, perché ognuno coltiva il sogno di diventare un giorno il padrone del favore, non più il mendicante.
Forse solo un conflitto armato, una di quelle tragedie che sconquassano le fondamenta di una nazione, potrebbe costringerci a un reset, a spezzare la catena e ricominciare da zero. Già, perché così è stato per i nostri padri e nonni. Sì… quelli che hanno vissuto il dopoguerra sanno cosa significa vedere un Paese in macerie e doverlo ricostruire partendo dalla fame, dalla cenere, dai sassi.
D'altronde basti osservare quanto sta accadendo in queste ore nella striscia di Gaza o in Ucraina per comprendere le difficoltà, per capire cosa significa perdere tutto e dover ricominciare con le mani nude. Come oggi, anche allora da noi – in quegli anni bui – accadde qualcosa di straordinario. Quando il pane era razionato e le città ed i suoi palazzi erano ridotti a scheletri di mattoni, la gente si aiutava, non per dovere, ma per necessità, perché l’altro era il fratello della stessa miseria.
Le donne dividevano l’ultima manciata di farina per fare una minestra, mentre i contadini – che nascondevano il grano – ora provavano a sfamare i vicini, gli operai viceversa iniziavano la ricostruzione con le mani nude, con la forza di chi non ha più niente da perdere. Se qualcuno volesse rivivere quei momenti, gli basterà osservare alcuni film neorealisti come "Ladri di biciclette" o "Roma città aperta"; in quei cortometraggi si racconta in modo reale la vita – in quel momento storico – del nostro Paese: non c’era eroismo, solo disperazione e una solidarietà che sgorgava spontanea, unico modo di sopravvivenza.
Persino i bambini raccoglievano cicche di sigarette per rivenderle, le donne facevano la fila per ore per un litro di latte annacquato. Eppure, in quella miseria, c’era una dignità che oggi sembra svanita, un senso di appartenenza che non si comprava, non si raccomandava, ma nasceva dal sangue e dalla terra. Forse perché allora si lottava per qualcosa di concreto: un tetto, un lavoro, un futuro. Oggi, invece, ci accontentiamo di illusioni e piccoli privilegi, mentre il sistema ci divora pezzo a pezzo, in silenzio.
Ma il dopoguerra insegnò anche altro: che la ricostruzione non fu solo merito degli aiuti americani del Piano Marshall. Fu soprattutto la gente comune, quella che non aveva niente da perdere, a rimettere in piedi l’Italia, mattone dopo mattone, con le unghie e con i denti. Senza aspettare che lo facessero i politici, già anche allora impegnati a spartirsi le poltrone, a costruire nuovi castelli di sabbia sulle macerie del vecchio mondo.
Chissà se serve davvero una nuova catastrofe per ritrovare quell’istinto di comunità, quel senso del noi che sembra ormai sepolto sotto tonnellate di individualismo e rancore. Sì… forse, semplicemente, abbiamo dimenticato troppo in fretta cosa significa aver fame, cosa significa non avere niente e dover costruire tutto. E soprattutto, cosa significa alzarsi insieme per cambiare le cose, non per interesse, ma per dignità.
Comunque, domani vi racconto la storia di cui vi ho accennato, vedrete… resterete senza parole.





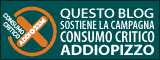

Nessun commento:
Posta un commento